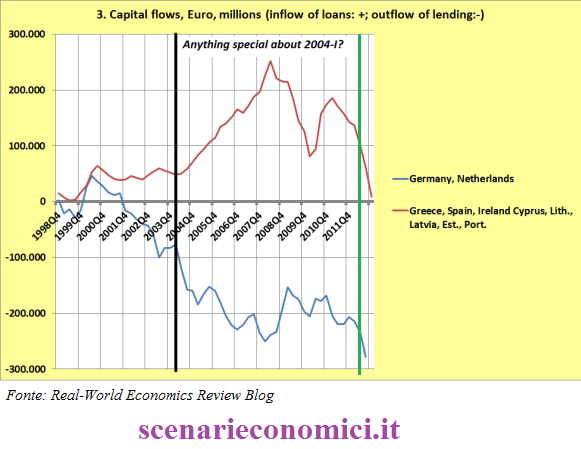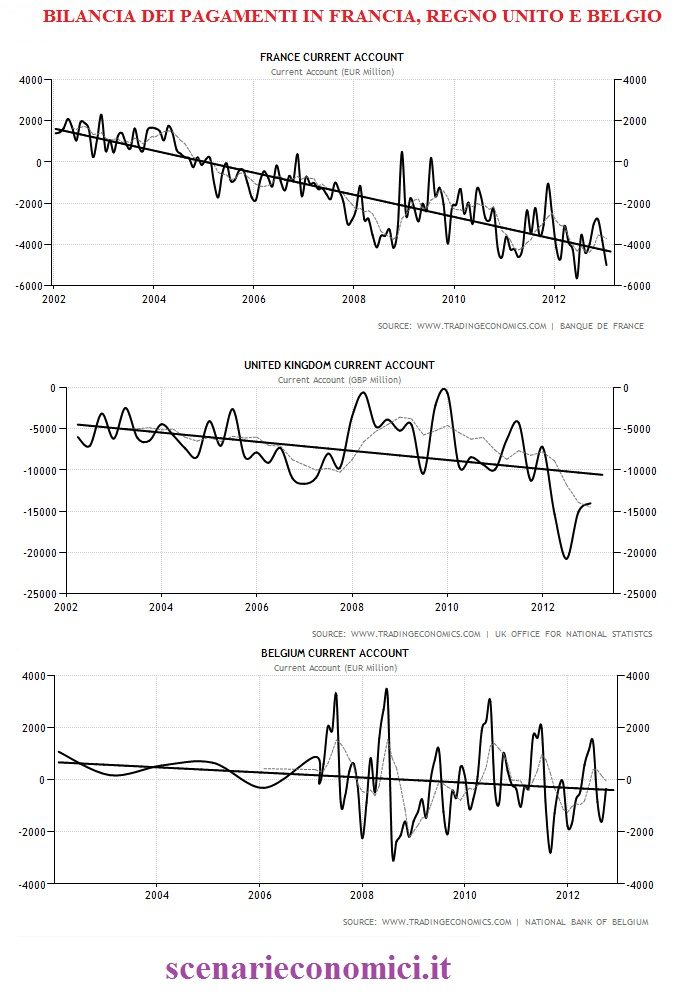Le privatizzazioni che hanno ucciso la società
Nel libro di Marco Bersani “CatasTroika” (appena uscito per Edizioni Alegre) un bilancio di ciò che le politiche liberiste e le privatizzazioni hanno prodotto negli ultimi quarant'anni, dall'America Latina alla Gran Bretagna, dalla Russia del post socialismo reale all'Europa occidentale. Anticipiamo un brano tratto dal capitolo: “Italia: dal Britannia al Titanic?”.
di Marco Bersani
Che il processo di privatizzazione in Italia abbia comportato una gigantesca ritirata dello Stato da un ruolo diretto nella produzione industriale e, più in generale, del “pubblico” nell’erogazione dei servizi, lo dimostrano alcuni semplici dati: complessivamente le operazioni hanno comportato proventi lordi per 134 miliardi, nonché risorse reperite totali, comprensive dell’indebitamento finanziario trasferito (14 miliardi) per 148 miliardi.
Alle 114 operazioni censite dal Barometro delle privatizzazioni (Bp) per il periodo 1985-2007, individuate escludendo quelle di importo superiore agli 80 milioni, ma considerando anche la dismissione di alcuni immobili (Torri del demanio dell’Eur) e delle società elettriche locali, corrispondono, invece, proventi pari a 152 miliardi.
In entrambi i casi l’Italia si è posizionata al secondo posto, dopo il Giappone, nella classifica globale per proventi da privatizzazioni.
Cifre che appaiono di importante dimensione, ma che in realtà, se paragonate con i successivi valori borsistici delle società privatizzate, come confermato dall’analisi della Corte dei Conti (delibera del 19 dicembre 2012), si rivelano una sorta di “saldi di fine stagione”, la stagione dell’intervento dello Stato nell’economia.
Più in generale, le operazioni di privatizzazione nel loro complesso hanno comportato il totale disimpegno dello Stato dai settori bancario, assicurativo, tabacchi e telecomunicazioni, nonché un consistente ridimensionamento delle partecipazioni, anche se non del controllo, nei settori strategici dell’energia (Eni ed Enel) e della difesa (Finmeccanica).
La conseguenza è stata che, a fronte di un peso del 18% nel 1991, il contributo al Pil delle imprese partecipate dall’amministrazione centrale è divenuta oggi pari al 4,7%.
Una trasformazione strutturale dell’economia di enormi proporzioni, rispetto alla quale occorre capire chi ne abbia tratto benefici e chi invece ne sia stato danneggiato.
 Un primo segnale non può che venire da uno sguardo sulle società di consulenza finanziaria – i famosi “contractors” – che hanno accompagnato i processi di privatizzazione, ottenendo compensi, attraverso ruoli plurimi tra le funzioni di advisor, valutatore, intermediario, collocatore e consulente, pari ad oltre 2,2 miliardi: si tratta, fra le altre, di Societè Generale, Rotschild, Credit Suisse First Boston, JP Morgan, Merril Lynch, Lehman Brothers, ovvero del gotha finanziario a livello internazionale.
Un primo segnale non può che venire da uno sguardo sulle società di consulenza finanziaria – i famosi “contractors” – che hanno accompagnato i processi di privatizzazione, ottenendo compensi, attraverso ruoli plurimi tra le funzioni di advisor, valutatore, intermediario, collocatore e consulente, pari ad oltre 2,2 miliardi: si tratta, fra le altre, di Societè Generale, Rotschild, Credit Suisse First Boston, JP Morgan, Merril Lynch, Lehman Brothers, ovvero del gotha finanziario a livello internazionale.
E infatti, la prima conseguenza evidente del processo di privatizzazione è stata quella di mettere la parola “fine” a qualsiasi possibilità di una finanza pubblica.
Agli inizi degli anni 90, l’Italia era il Paese europeo nel quale il controllo pubblico delle banche era il più elevato: il 74,5%, a fronte del 61,2% in Germania, e del 36% in Francia.
Il processo di riforma attuato ha portato all’azzeramento della proprietà pubblica nelle banche italiane, andando così ben oltre Germania e Francia, le quali, pur riducendo il controllo pubblico, hanno tuttavia mantenuto nel sistema bancario una presenza più che significativa, rispettivamente del 52% e 31%.
La deregolamentazione ha anche prodotto – com’è ovvio nella giungla del mercato – un forte processo di concentrazione, che, attraverso 566 acquisizioni e fusioni per un valore pari al 50% degli asset totali, ha drasticamente modificato il panorama bancario italiano, portando le quote di mercato dei cinque maggiori gruppi bancari dal 34 al 54%.
Se a tutto ciò si aggiunge la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti del 2003, con l’ingresso nel capitale sociale delle Fondazioni bancarie (30%), saldamente inserite nel controllo delle banche di riferimento, il quadro è abbastanza chiaro: le privatizzazioni hanno portato all’azzeramento di ogni funzione pubblica in campo economico e finanziario, con effetti pesanti direttamente riscontrabili nell’odierna crisi, che vede le scelte economiche del Paese sottostare, in totale sudditanza, alle dinamiche del sistema finanziario internazionale.
Uno dei risultati favorevoli, a più riprese sbandierato dai fautori delle privatizzazioni, riguarda i benèfici effetti delle stesse sul debito pubblico del Paese, avendo gli introiti delle dismissioni ridotto il rapporto debito/Pil nel periodo 1992-2004, con un risparmio in conto interessi di circa 38 miliardi.
Ma si tratta di un’illusione, sia quantitativa che qualitativa: perché, se nell’immediato si sono avute delle entrate, peraltro irrisorie se confrontate all’entità del debito pubblico, nel medio e lungo periodo le privatizzazioni hanno privato lo Stato di importanti entrate di cassa, nonché di assetti industriali che rappresentavano la spina dorsale dell’economia pubblica e del sistema di welfare che in parte si reggeva su di essa.
E se l’obiettivo dichiarato era quello di mettere in atto una liberalizzazione dell’attività economica favorendo la libera concorrenza, il risultato più evidente è stata la consegna a monopoli privati di attività e servizi gestiti precedentemente dal pubblico, comportando una trasformazione delle stesse, da funzione sociale a funzione unicamente finalizzata alla redditività economica. Questo perché l’obiettivo prioritario dei processi di privatizzazione era in realtà quello di dare un forte impulso ai mercati finanziari, come dimostra il fatto che, dal 1992 al 2007, la capitalizzazione del mercato borsistico domestico sia cresciuta di sette volte e il volume degli scambi sia aumentato di ottantacinque volte. Variazioni tali da essere in larga parte attribuibili alla quotazione di imprese privatizzate, la cui abbondante offerta ha favorito una massiccia riallocazione da parte dei piccoli risparmiatori dai tradizionali impieghi in titoli di Stato al mercato azionario.
Processo, quest’ultimo, tutt’altro che frutto della libera scelta del “consumatore/risparmiatore”, bensì preciso risultato di una strategia perseguita riducendo drasticamente ogni attrattiva dei Buoni Ordinari del Tesoro e dando un definitivo colpo d’ala al mercato borsistico attraverso l’imposizione – governo Amato – di una tassa del 27% sugli interessi dei conti correnti, a fronte del 12,5% applicato ai guadagni da investimenti in Borsa. Questo processo è stato accompagnato e sostenuto dagli investitori esteri, che hanno sottoscritto sia titoli di Stato che titoli azionari delle nuove società privatizzate, divenendo in breve tempo attori chiave del sistema finanziario, fino a diventare, nell’attualità in corso, causa principale della sua odierna crisi verticale.
Contrariamente all’obiettivo più volte sbandierato di voler sviluppare la diffusione di un forte azionariato popolare e di affermare anche in Italia il modello delle public company, le politiche di privatizzazione hanno inoltre comportato processi di forte concentrazione – come del resto già avvenuto in Gran Bretagna – determinando soprattutto un accentramento del controllo, anche in assenza di una concentrazione della proprietà: allora come oggi, diversi gruppi industriali – e sempre più finanziari – controllano le società quotate pur senza possederne neppure lontanamente la maggioranza delle azioni.
Nei primi dieci gruppi quotati in Borsa, il capitale controllato è pari a quasi tre volte quello posseduto, e questo è reso possibile dal cosiddetto sistema “delle scatole cinesi”: il possesso da parte di una holding del 51% di una società, che a sua volta possiede il 51% di un’altra, la quale possiede il 40% di un’altra ancora, che possiede il 30% di un’ultima società, quella che realmente interessa. Solo per fare un esempio, con questo sistema, Tronchetti Provera ha ottenuto il controllo della Olivetti – e quindi di Telecom e Tim – pur avendo comprato solo il 29% delle azioni della società. Dentro questo modello, aldilà delle favole sulla democrazia economica, si comprende bene quale possa essere il ruolo dei piccoli investitori: mettere i soldi nella società, permettendo agli azionisti maggiori di poterla controllare senza doverla possedere.
Decisamente pesante è stato l’impatto sociale delle privatizzazioni sul versante dell’occupazione e riguardo alle conseguenze per gli utenti.
Nel mondo del lavoro, le privatizzazioni hanno coinvolto 225.000 lavoratori, dei quali 125.000 nel settore delle telecomunicazioni, 25.000 in quello siderurgico, 24.000 in quello meccanico, 22.000 nell’alimentare e della distribuzione, 14.000 nei trasporti e infrastrutture.
Nel contempo, i cittadini si sono trovati di fronte ad un generalizzato peggioramento della qualità dei servizi e ad un costante aumento dei prezzi, in particolare nei settori dei servizi bancari, di quelli infrastrutturali (autostrade) e delle utilities (acqua, energia e gas), con tariffe notevolmente più elevate in proporzione a quelle applicate dagli altri paesi europei.
Di fatto le privatizzazioni non hanno fatto altro che consentire il trasferimento di ciò che prima era in mano pubblica – dunque di proprietà dei cittadini attraverso lo Stato – ad alcune poche mani private, spesso di gruppi finanziari che non aspettavano altro che settori monopolistici ad alta redditività per poter ottenere profitti con rischio industriale nullo.
Emblematico da questo punto di vista il caso delle autostrade: un vero e proprio regalo al gruppo Benetton, che ha ottenuto una rendita garantita con un rischio imprenditoriale nullo; ha potuto così permettersi di attuare investimenti minimi e contare su tariffe più alte della stessa inflazione, mentre il contribuente ha continuato a farsi carico delle spese per la rete in aree meno ricche e più a rischio (autostrada Salerno - Reggio Calabria e grande viabilità interregionale).
Da un punto di vista strategico-economico, le privatizzazioni hanno prodotto anche il nefasto risultato di segnare per il nostro Paese l’ultimo passo del processo generale di deindustrializzazione avviato un trentennio prima, completandolo con uno specifico processo di destatalizzazione.
Con lo slogan “privato è bello, il pubblico non funziona”, si sono messi nelle mani di alcuni privati, importanti settori strategici come quello bancario ed assicurativo, delle telecomunicazioni, siderurgico ed alimentare, continuando ad affermare come il processo di privatizzazione abbia riguardato primariamente l’industria pubblica in difficoltà, quando tutti i dati economici dimostrano il contrario: il 64,8% delle aziende privatizzate apparteneva ai settori bancario assicurativo e delle telecomunicazioni, finanziariamente remunerativi già sotto la gestione pubblica.
Ma i dati sono nulla a fronte del fondamentalismo ideologico, che ha attraversato e permeato tutte le culture politiche ed amministrative.
Ed è stata soprattutto la sinistra, tesa a far dimenticare la colpa di aver voluto in passato cambiare il mondo e bisognosa di farsi accreditare come affidabile dai mercati finanziari, ad interiorizzare le privatizzazioni come mito riformista e modernizzatore, e ad offrire in pasto ai gestori della finanza attività perfette per montarvi operazioni speculative, garantite dalla dinamica nel tempo dei flussi di cassa.
Nonostante i disastrosi risultati a livello economico, occupazionale e sociale, ormai da diversi anni è in atto addirittura un tentativo di radicalizzare le politiche di privatizzazione, coinvolgendovi altri importanti settori di rilievo sociale, come previdenza, sanità, istruzione, poste, trasporti e servizi pubblici locali.
Questa volta senza bisogno di salire a bordo di un fastoso quanto pittoresco panfilo reale, bensì occupando le grigie stanze del Ministero dell’Economia: è lì che, a fine settembre 2011, l’allora ministro Tremonti ha chiamato a raccolta i grandi investitori italiani ed internazionali, il gotha del sistema bancario e delle investment banks globali per sottoporre loro una sorta di “Britannia 2”, ovvero un altro mastodontico processo di dismissione del patrimonio pubblico del Paese, questa volta totalmente incentrato sul patrimonio immobiliare demaniale e comunale e sulle utilities locali.
Piano ripreso con vigore dal successivo governo “tecnico” guidato da Mario Monti con l’obiettivo, naturalmente, di ridurre il debito pubblico e promuovere la crescita del Paese.
La stessa strategia seguita dai primi violini dell’orchestra, che continuarono a suonare mentre il Titanic andava inesorabilmente a sbattere contro l’iceberg.
(30 aprile 2013)
di Marco Bersani
Che il processo di privatizzazione in Italia abbia comportato una gigantesca ritirata dello Stato da un ruolo diretto nella produzione industriale e, più in generale, del “pubblico” nell’erogazione dei servizi, lo dimostrano alcuni semplici dati: complessivamente le operazioni hanno comportato proventi lordi per 134 miliardi, nonché risorse reperite totali, comprensive dell’indebitamento finanziario trasferito (14 miliardi) per 148 miliardi.
Alle 114 operazioni censite dal Barometro delle privatizzazioni (Bp) per il periodo 1985-2007, individuate escludendo quelle di importo superiore agli 80 milioni, ma considerando anche la dismissione di alcuni immobili (Torri del demanio dell’Eur) e delle società elettriche locali, corrispondono, invece, proventi pari a 152 miliardi.
In entrambi i casi l’Italia si è posizionata al secondo posto, dopo il Giappone, nella classifica globale per proventi da privatizzazioni.
Cifre che appaiono di importante dimensione, ma che in realtà, se paragonate con i successivi valori borsistici delle società privatizzate, come confermato dall’analisi della Corte dei Conti (delibera del 19 dicembre 2012), si rivelano una sorta di “saldi di fine stagione”, la stagione dell’intervento dello Stato nell’economia.
Più in generale, le operazioni di privatizzazione nel loro complesso hanno comportato il totale disimpegno dello Stato dai settori bancario, assicurativo, tabacchi e telecomunicazioni, nonché un consistente ridimensionamento delle partecipazioni, anche se non del controllo, nei settori strategici dell’energia (Eni ed Enel) e della difesa (Finmeccanica).
La conseguenza è stata che, a fronte di un peso del 18% nel 1991, il contributo al Pil delle imprese partecipate dall’amministrazione centrale è divenuta oggi pari al 4,7%.
Una trasformazione strutturale dell’economia di enormi proporzioni, rispetto alla quale occorre capire chi ne abbia tratto benefici e chi invece ne sia stato danneggiato.
 Un primo segnale non può che venire da uno sguardo sulle società di consulenza finanziaria – i famosi “contractors” – che hanno accompagnato i processi di privatizzazione, ottenendo compensi, attraverso ruoli plurimi tra le funzioni di advisor, valutatore, intermediario, collocatore e consulente, pari ad oltre 2,2 miliardi: si tratta, fra le altre, di Societè Generale, Rotschild, Credit Suisse First Boston, JP Morgan, Merril Lynch, Lehman Brothers, ovvero del gotha finanziario a livello internazionale.
Un primo segnale non può che venire da uno sguardo sulle società di consulenza finanziaria – i famosi “contractors” – che hanno accompagnato i processi di privatizzazione, ottenendo compensi, attraverso ruoli plurimi tra le funzioni di advisor, valutatore, intermediario, collocatore e consulente, pari ad oltre 2,2 miliardi: si tratta, fra le altre, di Societè Generale, Rotschild, Credit Suisse First Boston, JP Morgan, Merril Lynch, Lehman Brothers, ovvero del gotha finanziario a livello internazionale.E infatti, la prima conseguenza evidente del processo di privatizzazione è stata quella di mettere la parola “fine” a qualsiasi possibilità di una finanza pubblica.
Agli inizi degli anni 90, l’Italia era il Paese europeo nel quale il controllo pubblico delle banche era il più elevato: il 74,5%, a fronte del 61,2% in Germania, e del 36% in Francia.
Il processo di riforma attuato ha portato all’azzeramento della proprietà pubblica nelle banche italiane, andando così ben oltre Germania e Francia, le quali, pur riducendo il controllo pubblico, hanno tuttavia mantenuto nel sistema bancario una presenza più che significativa, rispettivamente del 52% e 31%.
La deregolamentazione ha anche prodotto – com’è ovvio nella giungla del mercato – un forte processo di concentrazione, che, attraverso 566 acquisizioni e fusioni per un valore pari al 50% degli asset totali, ha drasticamente modificato il panorama bancario italiano, portando le quote di mercato dei cinque maggiori gruppi bancari dal 34 al 54%.
Se a tutto ciò si aggiunge la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti del 2003, con l’ingresso nel capitale sociale delle Fondazioni bancarie (30%), saldamente inserite nel controllo delle banche di riferimento, il quadro è abbastanza chiaro: le privatizzazioni hanno portato all’azzeramento di ogni funzione pubblica in campo economico e finanziario, con effetti pesanti direttamente riscontrabili nell’odierna crisi, che vede le scelte economiche del Paese sottostare, in totale sudditanza, alle dinamiche del sistema finanziario internazionale.
Uno dei risultati favorevoli, a più riprese sbandierato dai fautori delle privatizzazioni, riguarda i benèfici effetti delle stesse sul debito pubblico del Paese, avendo gli introiti delle dismissioni ridotto il rapporto debito/Pil nel periodo 1992-2004, con un risparmio in conto interessi di circa 38 miliardi.
Ma si tratta di un’illusione, sia quantitativa che qualitativa: perché, se nell’immediato si sono avute delle entrate, peraltro irrisorie se confrontate all’entità del debito pubblico, nel medio e lungo periodo le privatizzazioni hanno privato lo Stato di importanti entrate di cassa, nonché di assetti industriali che rappresentavano la spina dorsale dell’economia pubblica e del sistema di welfare che in parte si reggeva su di essa.
E se l’obiettivo dichiarato era quello di mettere in atto una liberalizzazione dell’attività economica favorendo la libera concorrenza, il risultato più evidente è stata la consegna a monopoli privati di attività e servizi gestiti precedentemente dal pubblico, comportando una trasformazione delle stesse, da funzione sociale a funzione unicamente finalizzata alla redditività economica. Questo perché l’obiettivo prioritario dei processi di privatizzazione era in realtà quello di dare un forte impulso ai mercati finanziari, come dimostra il fatto che, dal 1992 al 2007, la capitalizzazione del mercato borsistico domestico sia cresciuta di sette volte e il volume degli scambi sia aumentato di ottantacinque volte. Variazioni tali da essere in larga parte attribuibili alla quotazione di imprese privatizzate, la cui abbondante offerta ha favorito una massiccia riallocazione da parte dei piccoli risparmiatori dai tradizionali impieghi in titoli di Stato al mercato azionario.
Processo, quest’ultimo, tutt’altro che frutto della libera scelta del “consumatore/risparmiatore”, bensì preciso risultato di una strategia perseguita riducendo drasticamente ogni attrattiva dei Buoni Ordinari del Tesoro e dando un definitivo colpo d’ala al mercato borsistico attraverso l’imposizione – governo Amato – di una tassa del 27% sugli interessi dei conti correnti, a fronte del 12,5% applicato ai guadagni da investimenti in Borsa. Questo processo è stato accompagnato e sostenuto dagli investitori esteri, che hanno sottoscritto sia titoli di Stato che titoli azionari delle nuove società privatizzate, divenendo in breve tempo attori chiave del sistema finanziario, fino a diventare, nell’attualità in corso, causa principale della sua odierna crisi verticale.
Contrariamente all’obiettivo più volte sbandierato di voler sviluppare la diffusione di un forte azionariato popolare e di affermare anche in Italia il modello delle public company, le politiche di privatizzazione hanno inoltre comportato processi di forte concentrazione – come del resto già avvenuto in Gran Bretagna – determinando soprattutto un accentramento del controllo, anche in assenza di una concentrazione della proprietà: allora come oggi, diversi gruppi industriali – e sempre più finanziari – controllano le società quotate pur senza possederne neppure lontanamente la maggioranza delle azioni.
Nei primi dieci gruppi quotati in Borsa, il capitale controllato è pari a quasi tre volte quello posseduto, e questo è reso possibile dal cosiddetto sistema “delle scatole cinesi”: il possesso da parte di una holding del 51% di una società, che a sua volta possiede il 51% di un’altra, la quale possiede il 40% di un’altra ancora, che possiede il 30% di un’ultima società, quella che realmente interessa. Solo per fare un esempio, con questo sistema, Tronchetti Provera ha ottenuto il controllo della Olivetti – e quindi di Telecom e Tim – pur avendo comprato solo il 29% delle azioni della società. Dentro questo modello, aldilà delle favole sulla democrazia economica, si comprende bene quale possa essere il ruolo dei piccoli investitori: mettere i soldi nella società, permettendo agli azionisti maggiori di poterla controllare senza doverla possedere.
Decisamente pesante è stato l’impatto sociale delle privatizzazioni sul versante dell’occupazione e riguardo alle conseguenze per gli utenti.
Nel mondo del lavoro, le privatizzazioni hanno coinvolto 225.000 lavoratori, dei quali 125.000 nel settore delle telecomunicazioni, 25.000 in quello siderurgico, 24.000 in quello meccanico, 22.000 nell’alimentare e della distribuzione, 14.000 nei trasporti e infrastrutture.
Nel contempo, i cittadini si sono trovati di fronte ad un generalizzato peggioramento della qualità dei servizi e ad un costante aumento dei prezzi, in particolare nei settori dei servizi bancari, di quelli infrastrutturali (autostrade) e delle utilities (acqua, energia e gas), con tariffe notevolmente più elevate in proporzione a quelle applicate dagli altri paesi europei.
Di fatto le privatizzazioni non hanno fatto altro che consentire il trasferimento di ciò che prima era in mano pubblica – dunque di proprietà dei cittadini attraverso lo Stato – ad alcune poche mani private, spesso di gruppi finanziari che non aspettavano altro che settori monopolistici ad alta redditività per poter ottenere profitti con rischio industriale nullo.
Emblematico da questo punto di vista il caso delle autostrade: un vero e proprio regalo al gruppo Benetton, che ha ottenuto una rendita garantita con un rischio imprenditoriale nullo; ha potuto così permettersi di attuare investimenti minimi e contare su tariffe più alte della stessa inflazione, mentre il contribuente ha continuato a farsi carico delle spese per la rete in aree meno ricche e più a rischio (autostrada Salerno - Reggio Calabria e grande viabilità interregionale).
Da un punto di vista strategico-economico, le privatizzazioni hanno prodotto anche il nefasto risultato di segnare per il nostro Paese l’ultimo passo del processo generale di deindustrializzazione avviato un trentennio prima, completandolo con uno specifico processo di destatalizzazione.
Con lo slogan “privato è bello, il pubblico non funziona”, si sono messi nelle mani di alcuni privati, importanti settori strategici come quello bancario ed assicurativo, delle telecomunicazioni, siderurgico ed alimentare, continuando ad affermare come il processo di privatizzazione abbia riguardato primariamente l’industria pubblica in difficoltà, quando tutti i dati economici dimostrano il contrario: il 64,8% delle aziende privatizzate apparteneva ai settori bancario assicurativo e delle telecomunicazioni, finanziariamente remunerativi già sotto la gestione pubblica.
Ma i dati sono nulla a fronte del fondamentalismo ideologico, che ha attraversato e permeato tutte le culture politiche ed amministrative.
Ed è stata soprattutto la sinistra, tesa a far dimenticare la colpa di aver voluto in passato cambiare il mondo e bisognosa di farsi accreditare come affidabile dai mercati finanziari, ad interiorizzare le privatizzazioni come mito riformista e modernizzatore, e ad offrire in pasto ai gestori della finanza attività perfette per montarvi operazioni speculative, garantite dalla dinamica nel tempo dei flussi di cassa.
Nonostante i disastrosi risultati a livello economico, occupazionale e sociale, ormai da diversi anni è in atto addirittura un tentativo di radicalizzare le politiche di privatizzazione, coinvolgendovi altri importanti settori di rilievo sociale, come previdenza, sanità, istruzione, poste, trasporti e servizi pubblici locali.
Questa volta senza bisogno di salire a bordo di un fastoso quanto pittoresco panfilo reale, bensì occupando le grigie stanze del Ministero dell’Economia: è lì che, a fine settembre 2011, l’allora ministro Tremonti ha chiamato a raccolta i grandi investitori italiani ed internazionali, il gotha del sistema bancario e delle investment banks globali per sottoporre loro una sorta di “Britannia 2”, ovvero un altro mastodontico processo di dismissione del patrimonio pubblico del Paese, questa volta totalmente incentrato sul patrimonio immobiliare demaniale e comunale e sulle utilities locali.
Piano ripreso con vigore dal successivo governo “tecnico” guidato da Mario Monti con l’obiettivo, naturalmente, di ridurre il debito pubblico e promuovere la crescita del Paese.
La stessa strategia seguita dai primi violini dell’orchestra, che continuarono a suonare mentre il Titanic andava inesorabilmente a sbattere contro l’iceberg.
(30 aprile 2013)
 È raro che i dibattiti economici si concludano con un ko tecnico. Tuttavia, il dibattito che oppone keynesiani ai fautori dell’austerità si avvicina molto a un simile esito.
È raro che i dibattiti economici si concludano con un ko tecnico. Tuttavia, il dibattito che oppone keynesiani ai fautori dell’austerità si avvicina molto a un simile esito.